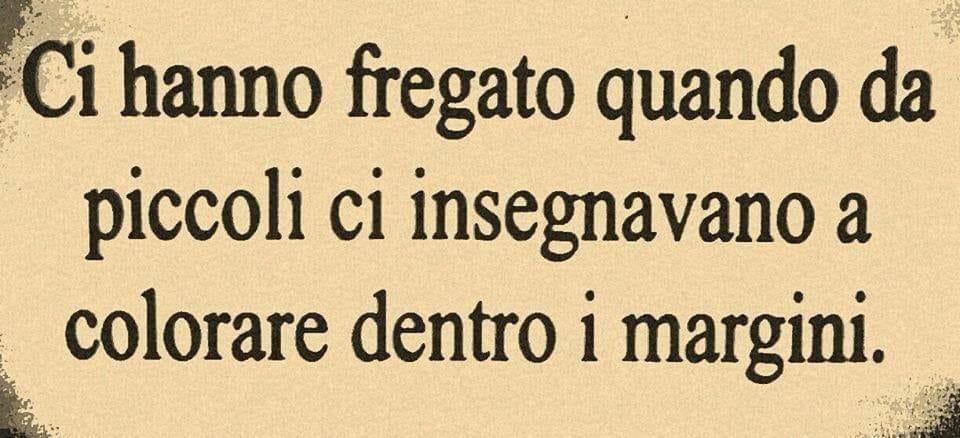Escursione effettuata: 26 luglio e 04-05 agosto 2020
Localizzazione: Val di Bon, proseguimento della Valpiana (Ossana), Adamello – Presanella
Premetto subito: sono particolarmente ‘affezionata’ a questa escursione. Ho lasciato un pezzetto del mio cuore al Bivacco Jack Canali ed ora vi spiego perchè.
Il giorno 26 luglio decido di effettuare un’escursione partendo dalla Valpiana (sopra Ossana, Val di Sole), proseguendo per la Val di Bon ed il Lago Venezia. Avevo deciso di andare lì per una frase che avevo letto: ‘L’escursionista non chieda alla Val di Bon quello che la Val di Bon, fortunatamente, non può offrire. Nessuna strada e nessun impianto di risalita, ma nemmeno accessi agevoli e sentieri comodi. Incontrare anima viva lungo il percorso non è affatto scontato…’ era il MIO POSTO IDEALE!!!
Ho lasciato la macchina poco dopo il Capitello di Sant’Antonio in Valpiana (mt. 1200) e mi sono incamminata sulla strada che per un tratto coincide col sentiero nr. 216. Poi, ad un certo punto si deve tenere la sinistra, dove diventa ufficialmente sentiero, e ci si addentra nel bosco fino a quando non si arriva alla Piana di Bon (in poco più di un’ora), dove si trova il bivio per l’ex Baito Caldura. Dalla Piana in 20 minuti su un ripido pendio si raggiunge lo Stalon di Bon (comodo ed accogliente bivacco, mt.1850). Poco dopo aver percorso un breve tratto in salita si raggiunge la Val di Bon ed il sentiero si fa più pianeggiante. Camminando tra bassi cespugli di ontano, ginepro e rododendro, si raggiunge il Lago Venezia (mt. 2046). A seconda del periodo e delle piogge, ci si può trovare davanti effettivamente ad un lago, o, talvolta, ad una conca verde!
L’idea originaria era, una volta arrivata al lago, di proseguire sul sentiero nr. 216 ed andare verso il Passo Scarpacò. Per fortuna (dico ora), guardando verso il passo, ho notato sulla ripida parete una striscia di neve/ghiaccio che mi ha dissuaso dal procedere in quella direzione. Essendo presto, ho deciso di proseguire dritto verso il Bivacco Jack Canali sul sentiero nr. 216A. Diciamo che non si tratta esattamente di un sentiero…sono massi su cui bisogna spesso saltare prestando molta attenzione. I segni colorati su questi massi talvolta sono poco chiari, ma comunque non ci si può perdere perchè si deve andare sempre dritti. Alla fine di questo erto pendio di massi, si deve tenere la destra (c’è un cartello…lo dico con un pò di meraviglia, perchè lassù sembra proprio di essere ai confini della realtà…).


Sempre saltellando sui massi, alla fine, in lontananza si scorge il bivacco (dopo 3h – 3h e 1/2 di cammino). Ed io, giuro, me ne sono innamorata a prima vista!


Il bivacco (mt. 2480), del tipo a semibotte in lamiera color rosso, è dominato a SO dalla parete NE di Cima Scarpacò e si trova in uno splendido anfiteatro roccioso. E’ dedicato alla memoria della guida alpina Jack Canali, ucciso da una valanga vicino a Sestriere. Da lì in poi non ci sono più sentieri. Le traversate al Rifugio Denza e al Rifugio Segantini si svolgono su terreno libero e richiedono sicuramente una certa esperienza alpinistica.
Ho fatto qualche foto coi ragazzi e poi con calma (visto il percorso) sono tornata sui miei passi.
Nei giorni successivi ho pensato molto a quel bivacco e, alla fine, ho deciso di trascorrervi la notte del 4 agosto per poter vedere l’alba il giorno del mio compleanno (5). E’ stata una delle esperienze più belle della mia vita.
Il 4 era un martedì. Mi sono svegliata la mattina che stava nevicando poco sopra i 2000 mt. Ho pensato di dover abbandonare l’idea. Ho quindi preparato 2 zaini: uno per una semplice giornata di trekking, un altro con tutto il necessario per fermarmi la notte. Ho parcheggiato la macchina in Valpiana e, per ingannare il tempo (era mattina), mi sono diretta verso il Lago di Barco. Quanta acqua che veniva giù! Alle 13 ho fatto ritorno alla macchina e lì dovevo prendere una decisione. Poco prima avevo chiesto ad un gestore di una malga se secondo lui la neve era arrivata fino al bivacco. Lui mi aveva risposto che a suo parere era poco più su. Stava ancora piovendo, ma le previsioni per il giorno dopo davano sole pieno.

E niente. Ho cambiato zaino e coi ragazzi, sotto la pioggia, ci siamo avviati lungo il sentiero per il bivacco. Siamo arrivati su verso le 16 fradici…
Ho sistemato le cose in qualche modo e poi mi sono insultata per ore per aver portato via solo un paio di calze…si moriva dal freddo! Mi sono messa sotto 10 coperte immobile, con il Nano e Bruno che dormivano sotto di me. Eppure, nonostante questa situazione di disagio, guardavo fuori dalla finestra del bivacco e mi sentivo al settimo cielo.
Ad un certo punto si avvicinava l’ora di cena e mi sono decisa ad uscire (con una coperta sulle spalle ed i piedi dentro a dei sacchetti di plastica perchè avevo gli scarponi bagnatissimi e solo un paio di calze…). Mi è spuntato un sorriso enorme: il cielo si stava aprendo e c’era un tramonto spettacolare!

Sono rientrata contentissima, ho dato da mangiare ai ragazzi e ho divorato la mia simmenthal con i fagiolini (ovviamente cena sconsigliata da qualsiasi nutrizionista in questi casi…). Poi, non avendo tanto da fare, sono andata a dormire (alle 20…però lì ci sta tutta!), sperando di non dover andare al bagno di notte. Apro una parentesi: in nessun momento ho avuto paura, nè quella notte, nè in generale durante le mie escursioni. C’è da dire però che sono una donna sola con due cani e che mi trovavo in un bivacco a quasi 2500 mt circondato dal nulla (forse proprio per quello che non avevo paura!). L’idea di uscire in piena notte al buio, lo ammetto, un pò di timore me lo incuteva…
Sotto il peso di quelle 10 coperte, dopo un bel pò, alla fine sono riuscita ad addormentarmi. Che dire… a mezzanotte ho aperto gli occhi perchè dovevo andare al bagno!!! Ho iniziato a pensare che se non ci fossi andata non sarei più riuscita a dormire e, alla fine, mi sono fatta coraggio e, coi ragazzi a fianco, ho lentamente aperto la porta. E giuro avevo di fronte lo spettacolo più bello della mia vita! Il cielo più stellato che abbia mai visto. La luna splendente che illuminava a giorno le pareti di quelle meravigliose montagne che mi circondavano. Un silenzio irreale. Trattenevo il respiro, rapita da così tanta bellezza. Non sarei più rientrata. Penso ricorderò quel momento per sempre.
Sono tornata dentro al bivacco ed ero la persona più tranquilla al mondo. Ho dormito. Dire bene magari è un pò eccessivo (il peso di tutte quelle coperte mi impediva di muovermi), però ho dormito fino a quando è suonata la sveglia poco prima dell’alba. Mi sono preparata una tazza di caffè solubile, una pagnotta con una candelina sopra e mi sono augurata buon compleanno, spegnendo la candelina. Sono poi uscita ad ammirare quella meravigliosa alba che porterò per sempre nel cuore.
Lentamente ho poi raccolto le nostre cose, infilato gli scarponi ancora fradici, e mi sono avviata verso la parete di massi, girandomi ripetutamente a guardare il bivacco col sorriso stampato sulle labbra, giurando che sarei sicuramente tornata. E così sarà.

Distanza totale percorsa: 15,67 km
Dislivello positivo: 1310 mt
Tempo movimento: 06:39:12
Commenti: quello che penso di quest’escursione credo si sia chiaramente capito. Devo essere sincera: è veramente una valle fuori dal mondo ed il pezzo che va al bivacco non è tra i più semplici. Io ho vissuto una magnifica esperienza e, probabilmente, questo mi fa vedere il resto in una prospettiva diversa.
Informazione tecnica: c’è acqua vicino al bivacco (fondamentale).